Confini. Scienza, storia e cronache tra limiti, mutamenti e migrazioni
28 Febbraio 2020
Tempo di lettura 1 minuti
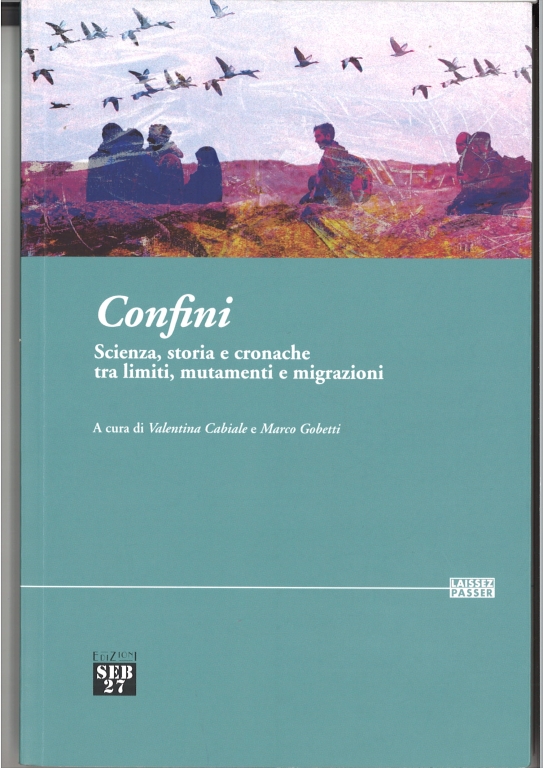
confini
Valentina Cabiale e Marco Gobetti (a cura di) Seb 27, 2019, pp. 158, € 15,00 Se si esclude quando covano e allevano i piccoli, i rondoni (da non confondere con le rondini, appartengono a due famiglie diverse) volano sempre, giorno e notte. Il migrare fa parte del loro ciclo vitale e percorrono dai 4 ai […]
Copyright © Nigrizia - Per la riproduzione integrale o parziale di questo articolo contattare previamente la redazione: redazione@nigrizia.it














